Professionisti al Vostro servizio |
|||||
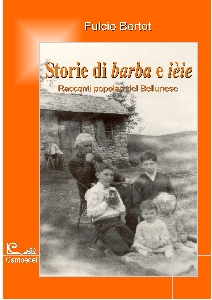
BORTOT FULCIOStorie di barba e ièie
Introduzione di Piero Francesco Franchi |
|
CON STUPORE E TREMORE: Ogni volta che muore un vecchio narratore, si usa dire a proposito dei popoli d'Africa che non hanno lingua scritta, è una biblioteca che brucia: tra quelle genti il racconto diretto, la tradizione orale delle conoscenze comuni è, per certi versi, ancora la norma e influenza molto il comportamento pratico, anche dopo una eventuale emigrazione nelle terre della tecnologia e della comunicazione solo razionale; e anche, soprattutto, malgrado l'invasione, nel cuore della tribù, di questa tecnologia e comunicazione razionale. I Bellunesi, per fortuna, non sono una tribù: da molti secoli diritto romano, cristianizzazione, alfabetizzazione, governo razionale, padronanza oggettiva della tecnologia, emigrazione e ritorni, politicizzazione e partecipazione diretta alla direzione delle proprie vicende, hanno abolito, nelle forme ufficiali, il linguaggio mitologico, la visione simbolica di cose e paesaggi, le credenze animistiche a proposito di acque, animali, luoghi. Ma a questa osservazione bisognerebbe accostare anche la constatazione che il miglioramento della società delle cose e delle merci non sempre e non dovunque e non necessariamente si accompagna con un miglioramento nella società degli uomini: la fonte primaria della tradizione orale di fiabe, miti, racconti fantastici, favole è essenzialmente lo stupore per la natura e il suo contenuto vivente, il timore per la possanza del tempo e del cielo, e la fraterna curiosità per l'evidente complessità dell'essere umano, per la sua preziosità nell'esistenza; e a ciò si accompagna la necessità di stare vicini nelle vicende del tempo e dello spazio, nelle difficoltà della vita, del lavoro, della morte, e del mistero. Non è solo un pensiero nostalgico, una specie di romanticismo dell'antica semplicità, quello che ci fa spesso rimpiangere usi e costumi distrutti dalle innovazioni, o ci addolora per la perdita di parole sapienziali, e la scomparsa (o trasformazione) di vecchie usanze: talvolta è proprio una necessità di difesa, poiché certamente, spesso, abbiamo perduto, nella nostra evoluzione o sviluppo o progresso o aumento di beni, insieme con qualche antico male, anche qualche antico bene. Così le fiabe, la sapienza popolare, le tradizioni, diventano oggetto di studi antropologici, reperti di un'archeologia spirituale che si possono elencare, numerare, confrontare, destrutturare: gli esiti di queste operazioni sono interessantissimi, e lo dimostrano le opere che si occupano delle "radici storiche dei racconti di fate", e della "morfologia della fiaba", trovando leggi e schemi di composizione, e arrivando fino a descrivere in formule, come fossero composti chimici, le narrazioni antiche della tradizione popolare. Ma le fiabe sono qualcosa di più, e anche hanno una natura irriducibile alla completa spiegazione: sono frammentarie, contraddittorie, spesso illogiche, dal momento che il mito -o la tradizione originaria- non viene più capito neanche dal narratore, che però ripete meglio che sa, e integra, talvolta con inconscia abilità, talvolta con intenzionale ripetizione di motivi altrui, un testo orale bucherellato per amnesie personali o collettive, sfilacciato dal tempo, stinto dall'antichità, e lacerato dai nuovi pensieri e dalle nuove tecnologie della sopravvivenza. La necessità originaria, però, resiste; e anche lo scienziato, l'antropologo, il folclorista deve rassegnarsi: "Di questa fonte comune nessuno conosce la profondità, ma ciascuno vi attinge a seconda dei suoi bisogni. … noi troviamo anche nelle leggende e nelle storie (che sono la rugiada cui si abbevera la poesia) analogie impressionanti e tuttavia indipendenti. Anche i miti e le leggende sono cose indispensabili all'esistenza, poiché solo là dove la brama di beni materiali o il frastuono delle macchine soffocano ogni altro pensiero, ci si può immaginare di vivere senza di loro. Ovunque prevalgano un ordine costituito e usanze salde, ovunque sia sentita la connessione fra il sentimento umano e la natura circostante, e il passato non sia avulso dal presente, queste tradizioni si ritrovano ancora": parole di Wilhelm Grimm, nel 1856. E' anche, istintualmente, l'opinione di Fulcio: "le famiglie del passato generavano sapienza, tramandata con le "Storie" … le storie sono una sintesi ed una risposta al mistero dell’esistenza". Questa raccolta ha tuttavia una caratteristica: non è una raccolta folclorica, una esplorazione sistematica della sapienza popolare su un territorio determinato; è dichiaratamente un libro memoriale, una fissazione su carta di emozioni intercorse tra vecchi e bambini all'interno di una sola famiglia, una rievocazione di care persone estinte nel corpo ma non nella voce, e permanenti nel gioco della fantasia, e nella nostalgia. Siamo dunque nel campo di una singolare operazione di commistione tra necessità di documentare e necessità di rimpiangere: situazione di solito poco felice per operazioni di corretta storiografia o analisi scientifica. Prendiamo dunque questi testi per ciò che l'Autore, che lo voglia o non lo voglia, li ha condotti ad essere: invenzioni familiari, creazioni di voci narranti privatamente, e familiarmente; che perciò ammantano strutture universali con la toponomastica locale, la Val Belluna e zone circostanti, (ma senza vera intenzione di spiegare un nome o una tradizione o una geografia): operazione spesso inefficace perché si limita a contestualizzare in un paesaggio personale un nucleo di racconto che resta spesso senza conclusione o spiegazione. Mi sono chiesto il senso di questa operazione puramente definitoria, nelle intenzioni di un vecchio narratore mio compaesano, e ne ho tratto una sola conclusione: il narratore vuole dare dignità di storia al racconto, attraverso una geografia nota; e mira evidentemente a informare i suoi piccoli ascoltatori dell'importanza del territorio, li vuole radicare quasi in un orgoglio etnico, come dicesse che queste meraviglie sono accadute qui, e dunque possono o potranno riaccadere, e dunque chi vive qui, vive in un territorio prodigioso. E non posso che essere d'accordo, se non con il metodo, almeno con lo scopo; e anche per quanto riguarda il metodo, forse anch'io preferirei sentirmi bellunese non a causa delle carte catastali e di anagrafe, o dei verbali di polizia o delle statistiche economiche, ma perché so il segreto di quella rupe o di quella fonte. La dolomite, nella psiche dei Bellunesi, non è solo carbonato doppio di calcio e magnesio, e san Mamante, nel profondo, è qualcosa di più del relitto di un rito pagano. Ho avuto anche un altro problema di interpretazione, nella lettura di questi venticinque pezzi di una saga che ha evidenti connessioni unitarie: la sorprendente rappresentazione del Diavolo all'interno di un rituale familiare: chi ha raccontato queste storie ha una sua personale teologia, che non coincide con quella che ci aspetteremmo da vecchi contadini e artigiani, cattolici da sempre; "venticinque storie, narrate ripetutamente mezzo secolo fa dai miei cari," le chiama il raccoglitore (anche se può essere parzialmente, inconsciamente, l'Autore). Il Diavolo, per esempio, non è un'entità direttamente contrapposta a Dio, ma, come i Santi sono a subalterni a Dio, così il Diavolo lo è a Satana (e talvolta lo bestemmia come farebbe un nostro indigeno con la divinità), e questa è una posizione ai limiti dell'eresia gnostica; questo Diavolo ha i suoi tabernacoli, da onorare e venerare; e, se appare spesso come tentatore, appare anche come garante di giustizia. Le sue apparizioni sono sempre preannunciate da descrizioni, letterariamente improprie, perché tolgono l'elemento sorpresa, ma psicologicamente efficaci, su una mente bambina, perché rassicurano sulla "normalità" e "necessità" dell'apparizione: "protetti dalla quiete dei ritmi naturali," come dice Fulcio. Ci sono certo residui di antica mitologia (il fabbro di Borgo Pra è quasi un Efesto, con la sua adultera e bellissima Afrodite), ma soprattutto elementi di una teologia molto personale, e non discutiamo ora se siano elementi sciamanici od eretici: È proprio così: gli esseri infernali e quelli del cielo sono sempre presenti, anche se spesso non ce ne accorgiamo … Pùtolo fa parte di quei personaggi che sono sempre esistiti e che non moriranno mai; non sono soggetti alle leggi della natura, sono degli spiriti che hanno assunto sembianze umane solo per rendere il mondo peggiore e per fare del male … una di quelle creature dei boschi e delle montagne che conoscono i segreti delle erbe magiche e delle scienze naturali; un essere differente sia dalle streghe che dalle fate … Tra la gente rimane ancora la convinzione che fossero degli spiriti di chissà quale mondo, mandati sulla terra per espiare chissà quale colpa. Appaiono anche elementi di cultura politica (nella storia di Fiorellino si reclama, per esempio, la felicità contemporanea di tutte le genti del mondo, vasto obiettivo da Nazioni Unite), e di incerta adesione ai beni dello sviluppo-progresso ("Molti, ma proprio molti anni fa, quando non c’erano ancora né le macchine né l’elettricità"). La lingua della narrazione presenta registri variati, tra il ricordo delle parole del narratore, e l'istinto di chi trascrive ora il testo: ci sono alcuni elementi antichi di autenticità diretta, dialettismi (solo un vero indigeno direbbe "governati gli animali") che convivono con elementi di linguaggio televisivo, o addirittura da cartoon disneyano ("nipotastri"), e, comunque, neanche ad ammazzarlo un autentico vecchio indigeno direbbe "il giovane si aggirava assorto tra recinti e box": ma anche il raccoglitore (il bambino cresciuto anche grazie a questi racconti) ha i suoi diritti linguistici. Pare invece molto autentico, e un po' gaglioffo, il ricordo del vecchio di certe estinte istituzioni presenti in Belluno ("i buontemponi fecero tappa in via Mezzaterra a trastullarsi con certe allegre donnine"), ed è contemporaneamente curiosa (ma affine a certi vecchi scrittori austriacanti) la sua coscienza storica ("ancor oggi, permane uno stretto legame tra la nobiltà bellunese e quella altoatesina"). Questo insieme narrativo non ci presenta sempre un racconto consolante o consolatorio: più spesso sembra una preparazione alle difficoltà della vita, con momenti di grandioso pessimismo: "Tu devi essere certamente il Diavolo - fece il Re - perciò mi devi dire se giù, nel tuo regno, l’inferno, i demoni ed i dannati sono così cattivi come gli abitanti della terra." Ma il demonio, fingendo di condurlo all'inferno, in realtà abbandona il Re, che ha il pericolosissimo dono di leggere il pensiero autentico degli uomini, proprio sulla terra, nella storia, nel cuore del reale; pare di sentirlo, il vecio Barba, che insegna solenne a bambini sgomenti: "l'inferno è qui, intorno a te, preparati senza rassegnarti, lo scopo della vita è far fiorire il deserto, e il diavolo non ha colpe se tu non lo fai". De te fabula narratur, direbbe un antico. Francesco Piero Franchi Belluno, San Nicolò 2005.
|